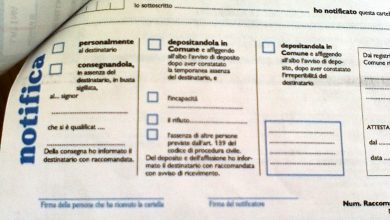Parecchio tempo fa questa rubrica, affrontando il tema della responsabilità per aver insultato il proprio datore di lavoro, aveva citato tra le sentenze più curiose quella del 31 maggio 2017, concernente il licenziamento del dipendente colpevole di aver criticato il proprio capo su facebook.
L’azienda in questione, cui la Corte d’appello aveva imposto non solo il risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal momento della cessazione del rapporto lavorativo al saldo, ma anche la reintegra della persona lasciata a casa, ha a quell’epoca presentato ricorso dinnanzi alla Suprema Corte nella speranza che le proprie ragioni trovassero accoglimento.
La società ha rilevato la circostanza che i giudici del secondo grado non avessero concretamente applicato il nuovo articolo 18 della storica Legge 300/70, nella parte in cui lo stesso riconosce la tutela reintegratoria “solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata, non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente”.
Rigettando in toto il ricorso, la Cassazione aveva in quella pronuncia richiamato quanto già specificato nella sentenza n. 20540/15, ossia che il fatto dal quale è scaturito il licenziamento vada considerato “insussistente” anche qualora sia effettivamente sussistente ma privo del carattere di illiceità.
Partendo dal presupposto che nella fattispecie presa in esame le frasi asseritamente diffamatorie pubblicate sui social network non fossero di per sé illecite – conclusione, questa, non del tutto condivisibile – l’organo giudicante ha in quell’occasione previsto la tutela reintegratoria per la dipendente licenziata.
Posto che spesso e volentieri, come ormai i lettori più affezionati sanno bene, la Cassazione (assolutamente in modo legittimo, atteso che il nostro ordinamento non concepisce il precedente vincolante, proprio invece dei sistemi di common law) emette sentenze in direzione totalmente opposta, quest’oggi si intende accendere i riflettori su una recente pronuncia, di tutt’altro avviso.
Invero, gli Ermellini hanno cristallizzato il principio secondo il quale gli insulti al datore di lavoro rappresentano un reato, con la conseguente possibilità da parte della persona offesa di richiedere ed ottenere anche il risarcimento del danno, persino qualora siano pronunciati senza la vera intenzione di diffamare.
Nella caso questa volta in esame, l’impiegata di una residenza sanitaria – nell’ambito di una riunione – aveva definito i propri superiori dei “banditi”, alludendo implicitamente al fatto che non agissero in modo onesto e corretto. Ebbene, a parere della Suprema Corte tale affermazione integra senza dubbio alcuno la diffamazione, delitto che si consuma anche se si utilizza una parola a sproposito, magari non intendendo conferirgli il significato letterale che le appartiene.
In buona sostanza, è stato ritenuto sufficiente il “dolo eventuale”, ossia l’utilizzo di espressioni che, a prescindere dall’intenzione specifica di offendere la reputazione altrui e dalla conoscenza del significato specifico delle parole dette, possano essere interpretate come offensive da chi le ascolta.
Beh, senza voler alimentare inutili polemiche, è ovvio che susciti qualche perplessità questa marcata differenziazione tra la prima e la seconda situazione prospettata, atteso che determinate critiche pubblicate sui social network certamente possono dimostrarsi molto più lesive dell’immagine di una società, rispetto a due parole (di sicuro inopportune) dette nel corso di una riunione a porte chiuse.
Roberta Romeo